Del grande ed elegante volume "Viaggio in Terra di Brindisi",
di Angela Marinazzo (direttrice del Museo Archeologico Provinciale),
tratteggiamo le tradizioni della provincia.
Dal volume di Angela Marinazzo "Viaggio In Terra di Brindisi"
Il culto religioso e i cortei storici
Le tradizioni della nostra provincia, come di tanti altri territori, sono strettamente legate alla storia economica e religiosa. Le più note sono la processione del "cavallo parato" del Corpus Domini a Brindisi; la cavalcata di S. Oronzo a Ostuni, che si tiene nell'ultima settimana di agosto; il torneo dei rioni e il corteo storico di Federico II a Oria, che si svolgono di regola nella prima decade di agosto; lo sbandieramento della "nzegna" (l'insegna) a Carovigno, nel martedì di Pasqua, per la festa della Madonna di Belvedere; il corteo storico della Madonna del Pozzo, che si svolge a Fasano nella seconda metà di giugno; l'asta della bandiera a San Pietro Vernotico nel giorno di Pasqua; oltre alle feste patronali, massima espressione della religiosità popolare con i culti mariani, che includono la Madonna della Fontana a Francavilla, la Madonna di Galeano a Torchiarolo e la Madonna di Iaddico a Brindisi.
Il "cavallo parato"

Processione conl'ostentazione dell'Ostia consacrata con il Cavallo Parato
Foto coll. Nolasco
La solenne processione del "cavallo parato" del Corpus Domini a Brindisi è un rito unico nella storia della Cristianità, che si svolge da più di sette secoli: l'episodio che ne è all'origine merita di essere raccontato, sia pure sommariamente. Nel maggio o giugno 1250, Luigi IX, re di Francia (sarebbe stato fatto santo nel 1297), tornava dalla sua prima avventurosa crociata in Terra Santa quando la nave approdò, molto probabilmente spinta da una tempesta, sullo "scoglio" o promontorio che si trova a Sud del nostro porto, presto chiamato, o ribattezzato per il motivo che si vedrà, Capo Cavallo o Torre del Cavallo. Il re dei Francesi, fratello di Carlo I d'Angiò che in quell'occasione lo accompagnava, portava con sé (ed anche questo era un privilegio unico nella storia della Chiesa) l'Ostia Consacrata. Per ricevere il re e la SS. Eucaristia, si mosse dalla città l'Arcivescovo di Brindisi Pietro III, seguito dal clero e dal popolo (tant'è che la città si spopolò quel giorno), e - data la distanza, oltre che per la sua età avanzata - vi andò a cavallo come, si può facilmente immaginare, fecero tutti quelli che avevano una cavalcatura. La processione, solenne, con l'Arcivescovo che portava il Calice con l'Ostia riparato da un ricco baldacchino, mentre il suo cavallo era tenuto al freno da re Luigi e dall'imperatore Federico II, terminò alla Cattedrale dove venne deposto il SS. Sacramento; e si ripete da secoli, più o meno invariata, salvo il tragitto ora tutto interno al centro storico. Per la storia, Luigi IX (o Ludovico, forma medievale di Luigi) morì di peste il 25 agosto 1270, appena sbarcato a Tunisi per la sua seconda crociata; il fratello Carlo I fece costruire la torre di Capo Cavallo dal 1274 al 1279; la festa del Corpus Domini, già celebrata a Liegi, fu estesa nel 1264 a tutta la Chiesa dal papa francese Urbano IV; mentre la "processione" del Corpus, solenne e obbligatoria, fu disposta da un altro papa francese, Giovanni XXII, nel 1316, appena eletto.
La cavalcata in onore di S. Oronzo
Poche e incerte sono le notizie sulle origini della Cavalcata di S. Oronzo, che si svolge a Ostuni il 26 agosto, nella ricorrenza della festa del Santo. Oronzo nacque a Lecce da ricca famiglia pagana e fu convertito da un discepolo di Gesù, di nome Giusto: si dedicò all'evangelizzazione nel Salento e compì molti miracoli in agro di Ostuni, dove trovò rifugio in una grotta sulla collina che da lui prese il nome. Tornato a Lecce, i Romani lo catturarono e lo decapitarono nei pressi della città il 26 agosto dell'anno 68 (lo stesso in cui Nerone, persecutore dei cristiani, fu ucciso dai suoi pretoriani). La prima edizione documentata della Cavalcata in suo onore risale al 26 agosto 1657. L'anno precedente, la peste aveva infierito in diverse regioni risparmiando il Salento, per intercessione - si ritenne comunemente - del suo protettore Sant'Oronzo. Quel giorno la cavalcata era composta dai soldati della guarnigione, dal Sindaco e dagli altri amministratori e, naturalmente, da una grande folla di popolo. Alla solennità della cavalcata contribuisce molto l'elegante e caratteristica uniforme dei cavalieri: pantaloni bianchi, giubbotto rosso trinato, fascia rossa ai fianchi, chepì rosso trinato con cappuccio pure rosso cadente e terminante con fiocco dello stesso colore; il cavallo è coperto da un'ampia gualdrappa e da una mantiglia rossa ricamata e trinata di bianco.
Il torneo dei rioni e il corteo storico di Oria
Le origini del torneo dei rioni e del corteo storico a Oria risalgono al 1225. Quell'anno Federico II, che era in attesa di incontrare la sua futura sposa Jolanda di Brienne, soggiornò con la corte a Oria, nel castello che era stato appena ampliato e fortificato. L'Imperatore, per ingannare l'attesa e allietare i cortigiani, decise di bandire un torneo, spettacolo frequente e molto gradito in epoca medievale e rinascimentale. Da 35 anni Oria (che tra l'altro si è gemellata con Lorch, la cittadina tedesca di cui era originaria la famiglia di Federico lo Svevo), fa rivivere questa pagina della sua storia millenaria con una fastosa cerimonia, che si svolge nella prima decade di agosto. Il torneo dei quattro rioni (Castello, Giudea, Lama, San Basilio) prevede, nel rispetto delle regole dettate dal bando di Federico II, prove di forza, agilità, resistenza, abilità e velocità, e un premio costituito da un "magnifico" palio. E' preceduto dal corteo storico che vede sfilare, nei ricchi costumi d'epoca, centinaia di attori e comparse, con la partecipazione dell'intera città, adornata con drappi e bandiere.
La Madonna del Belvedere di Carovigno
e la Madonna del Pozzo di Fasano
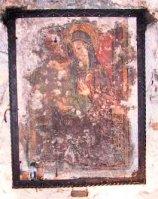 Madonna del Belvedere - Carovigno
Madonna del Belvedere - Carovigno
Foto coll. Pennetta
Il rinvenimento dell'immagine della Madonna nella grotta del Belvedere a Carovigno risalirebbe all'XI secolo, al tempo dei Normanni. Ad essa fu collegata la miracolosa guarigione di un signore di Conversano, poiché la stessa immagine gli era apparsa in sogno poco prima che fosse fortuitamente trovata. Lo sbandieramento della "nzegna", bandiera multicolore che viene fatta roteare nell'aria, prova di abilità in cui i Carovignesi sono diventati particolarmente bravi, tant'è che vengono spesso invitati ad esibirsi in Italia e all'estero, rappresenta un modo originale di dimostrare - il martedì di Pasqua - la propria devozione alla Vergine protettrice della città, nella processione che dal centro cittadino porta al Santuario di Belvedere. Un'altra immagine miracolosa della Madonna fu quella rinvenuta da alcuni contadini, intenti a scavare un pozzo, in una grotta in località Pozzo Faceto, nel territorio di Fasano. All'intercessione della Madonna del Pozzo, alla quale fu dedicato un Santuario, si deve una vittoria riportata dai Fasanesi sui Turchi il 2 giugno 1678.
L'asta della bandiera di San Pietro Vernotico
Al 1480, o poco più tardi, risale invece la vittoria dei Sampietrani sui Turchi che, dopo aver preso Otranto, facevano frequenti scorrerie nel Salento. Una vittoria festeggiata dai cittadini di San Pietro ogni anno, il giorno di Pasqua, con l'"asta della bandiera", che i Turchi sconfitti abbandonarono e i vincitori deposero ai piedi del simulacro del loro Protettore, da cui la città ha preso il nome.
Profondamente legati alla vita quotidiana e all'economia contadina e marinara sono i significati delle varie tradizioni, rimaste immutate in più secoli. La tarantella, i grandi falò, i Sepolcri del giovedì santo, gli Incappucciati del venerdì santo di Francavilla, i pellegrinaggi ai santuari dei SS. Medici a Oria, di S. Lucia a Erchie, di San Biagio a Ostuni, e al Santuario di Iaddico a Brindisi. E, poi, le sagre dell'uva a Casalini, in agro di Cisternino, delle lumache a Campo di Mare, sulla costa di San Pietro Vernotico, del polpo a Santa Sabina e del pesce spada a Savelletri. E ancora le fiere di San Giuseppe a Ostuni, in primavera; del bestiame a Ostuni e Cisternino, in estate; la Fiera dell'Ascensione a Francavilla, la Fiera-mostra del Ferragosto ostunese, la Fiera del Mediterraneo a Brindisi.
La gastronomia

Gastronomia - Foto Coll. F.Zongoli
Oltre al sole, al mare e alla collina, ma anche ai beni storici, artistici e monumentali, e a uno stile di vita che cerca costantemente di contemperare benessere materiale e spirituale, la provincia di Brindisi - come quelle vicine - offre una gastronomia sana e genuina, ricca di sapori, aromi e colori, affidata non ad una cucina elaborata ma ad alimenti semplici e fondamentali come il pane, le carni ovine e bovine, i formaggi, il pesce e i frutti di mare; gli ortaggi, l'olio, il vino.
Nei nostri paesi il pane viene ancora fatto in casa e cotto nei forni a legna. E' molto interessante ricostruire l'origine della "frisella", la ciambella biscottata molto in uso da noi soprattutto in estate: potrebbe essere stata importata dai primi navigatori greci, che la bagnavano nell'acqua di mare, così come probabilmente facevano i crociati e i pellegrini nei lunghi viaggi per raggiungere la Terra Santa. Pane, formaggio e vino costituivano la colazione e il pranzo dei contadini in campagna, spesso con l'aggiunta di cipolla cruda, che contribuiva a dar loro energia e la capacità di resistere per molte ore al duro lavoro dei campi.
In casa le donne cuocevano i legumi (ceci, lenticchie, piselli, fagioli e fave) a fuoco lento, accompagnandoli - quand'era possibile - con cozze nere e verdura cotta. Nei giorni festivi, si cucinava la pasta fatta in casa: le orecchiette e i maccheroncini con sugo di carne (braciole e polpette di cavallo o di manzo), ma pure la pasta al forno, con l'aggiunta di uova sode, mozzarella, salumi e polpettine di carne col ragù. Spesso si usava preparare una teglia di patate con agnello, o con riso e cozze nere (un piatto derivato dalla 'paella' dei nostri antenati spagnoli), che si portava a far cuocere nel forno a legna, un'istituzione ancora in piena attività in diversi Comuni della provincia.
Un buon pasto è sempre accompagnato dai generosi vini locali, soprattutto rossi e rosati, ma anche bianchi, ricavati in particolare da uve Negro amaro e Malvasia nera di Brindisi, ma pure Primitivo e Ottavianello. La dominante di tutti i piatti resta comunque l'olio d'oliva che, con il peperoncino, esalta il sapore del cibo. Gli antipasti terrestri sono costituiti dagli ortaggi locali conservati sott'olio, carciofi, melanzane, peperoni, cipolline, pomodori secchi, olive verdi e nere; quelli marini dalle cozze, dai ricci e dagli altri frutti di mare; da polipi e calamari, alici, sgombri, sarde e merluzzi. La zuppa di pesce è poi un piatto ricercatissimo nelle località della costa, e ha il pregio di cambiare ogni volta i suoi sapori, secondo i frutti di mare e le varietà di pesce disponibili.
Un secondo piatto molto gradito è quello ottenuto con le carni e le interiora del capretto e dell'agnello; ma spesso un'ottima parmigiana di melanzane o di zucchine, o i carciofi ripieni con pane grattugiato, uova e aromi, o la focaccia preparata con ingredienti e condimenti sempre diversi, costituiscono un pasto più che soddisfacente per la varietà, la freschezza e la ricchezza degli elementi nutritivi.
La frutta locale va dalle pesche alle pere, dai fioroni ai fichidindia, dalle ciliegie alle albicocche, dai meloni all'uva, dai fichi all'anguria, dalle mele cotogne alle mandorle. Queste ultime restano il principale ingrediente dei dolci tradizionali, anch'essi fatti di solito in casa, che rappresentano un altro - non trascurabile - motivo per apprezzare la gastronomia della nostra provincia.

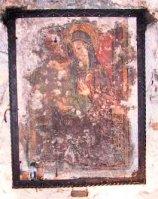 Madonna del Belvedere - Carovigno
Madonna del Belvedere - Carovigno
